Appuntamento - Venerdì 15 novembre 2013 presentazione di “Millimetri” di Milo De Angelis, ore 21.00 - Centro Culturale di Milano (via Zebedia, 2) con: Milo De Angelis, Angelo Lumelli e Luigi Tassoni. Intervengono, tra gli altri amici, Michelangelo Coviello, Fabrizio Fantoni. Fabio Jermini, Giancarlo Pontiggia, Luigia Sorrentino, Isabella Vincentini. Coordina l’incontro Alessandro Zaccuri. Per informazioni: stampa@ilsaggiatore.com “Millimetri” di Milo De Angelis, fu pubblicato nel 1983 da Einaudi. A 30 anni da quella pubblicazione il Saggiatore nella collana le Silerchie (euro 12,00) lo ripropone.
Dalla postfazione di Aldo Nove e Giuseppe Genna. Quando ho aperto per la prima volta Millimetri mi si è spalancato un mondo incomprensibile, ma di quel mondo avevo memoria. Ero un neonato che si guardava attorno. C’era solo il dovere arcaico di entrare in quel mondo, così come per ogni neonato. Avevo sedici anni anni ed è stata l’esperienza più forte che la poesia mi ha regalato. Leggevo quelle parole oscure ma necessarie ad alta voce sul pullman, al mattino presto, andando al liceo. Altri ragazzi ascoltavano. Alcuni ridevano, altri scuotevano la testa, qualcuno restava ammutolito. Poi c’era chi ripeteva i versi che leggevo, diceva che erano pazzeschi, che la poesia è una cosa pazzesca. Era l’esperienza di un campo di forze mai sperimentato prima da me. Conoscevo la tradizione approssimativamente, però in modo sufficiente da essere consapevole che venivo spinto verso voltaggi nuovi e antichissimi. La giunzione del tempo, in “Millimetri”, avviene per mutismi che non certificano un’impotenza del linguaggio - accade invece l’opposto. Erano anni di psicoanalisi ancora, però a nessun poeta o critico venne in mente di correlare alla poesia di Milo De Angelis l’operazione di una discesa nelle correnti telluriche dell’inconscio, questa sentina di fantasie livide che ha segnato certo Novecento. Non si possono accostare questi versi pensando a una scrittura automatica surrealista, come se fossero fenditure attraversate da fantasmi. C’è al contempo il cosmico e l’interiore, misteriosamente compresenti. Io stavo in quei flutti bui, venivo definendomi alla luce e all’oscurità di quelle immagini contemporanee e prive di tempo. La letteratura vivente si presenta con i crismi dell’indefinibile e del perentorio. Entravo nella mia vita grazie a quella poesia. Raramente la poesia può permettersi di gareggiare con l’esperienza. “Millimetri” è un’esperienza di lettura che diventa vita subito, bruciando lì perché della vita ha la stessa asprezza che nulla ha a che fare con il realismo, con qualsivoglia realismo. Se il realismo può cercare (senza ovviamente mai riuscirci) di porsi in modo mimetico nei confronti della vita, questi versi ne veicolano l’oscuro pulsare, l’essere nell’altrove di ogni giorno. Il mistero della consistenza dei sassi, il rapporto con i morti, il gusto della pizza. C’è qualcosa di ineffabile e osceno, di mistico e spaventosamente superficiale nell’elenco delle cose che messe assieme compongono la nostra esistenza. Milo De Angelis nel 1983 ha mostrato a molti le giunture di questo elenco, andando a capo “a caso” apparentemente, facendolo invece sempre secondo il Caso che domina la poesia di Lucrezio, che De Angelis ha tradotto stupendamente. L’aleatorio come scienza empirica e già data, il rumore delle parole che è sostanza (”Ciò che sussiste per se medesimo; Materia di cui è formato un corpo, ed in virtù della quale esso ha proprietà particolari; Ciò che vi è di essenziale, di nutriente e di succoso in qualche cosa; Somma, Ristretto di una cosa”, Ottorino Pianigiani, Dizionario etimologico della Lingua Italiana, 1907, Albrighi & Segati Ed.) La potenza dei versi di “Millimetri” è riconosciuta da Milo De Angelis in più interviste e non ha smesso di permanere, radiazione di fondo e quarta forza che si impone con lo spazio della sua inabitabilità. Sono apici che manifestano un ambiente in cui ogni vita poteva avere inizio e manifestare la sua fine senza preoccupazioni per il teatro del mondo. C’è molta corrispondenza con certo pop degli anni in cui sono cresciuto io - una corrispondenza sorprendente, isotopi della stessa sostanza: nella musica dei Kraftwerk, in certo cinema di Lynch, nella pittura consegnatami da Mark Rothko. Sembrerebbe inadatto accostare versi di poesie con prospettive che criticamente sono considerate esotiche. Tuttavia scatta un cortocircuito che lascia attoniti tra quelle opere e i versi di De Angelis, se solo si pensa che, a parte la critica costretta a un mutismo dal salto quantico praticato con Millimetri, il passaggio che più ha conquistato i moltissimi lettori di quella raccolta è: “In noi giungerà l’universo, | quel silenzio frontale dove eravamo | già stati”. E’ una sostanza cosmica che costituisce il portato della cultura e dell’arte di questi ultimi decenni: ciò che è stato e sarà lo sperimentale. “Ciò che è stato compreso non esiste più” ha scritto Paul Eluard. “Millimetri” di Milo De Angelis è un libro che non verrà mai capito del tutto e quindi esisterà sempre. Ma la sua compattezza ha delle crepe, e in quelle crepe il senso cade ed emerge di continuo e così il lettore, che procede per illuminazioni e oscurità simultanee, impossibili. Tanta poesia degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta si è compiaciuta della propria oscurità. Qua non c’è nessun compiacimento. Il limite è estremo e reale, mette in gioco tutto. La poesia di Millimetri spinge oltre la poesia, come la Nottola di Minerva prende il volo e non si sa dove arriverà ma prende il volo e ci strappa da noi. Procede testualmente, De Angelis, in una diminuzione delle referenze, che restano tuttavia incancellabili, portando implicito un assalto ai limiti della lingua, secondo il canone dantesco, “transumanar significar | per verba non si porìa”. E così in “Millimetri” si legge per esempio “Prendete allora | ciò che nel devo si inarca”, laddove si rende manifesta una poetica delle potenze che sfuggono al nome, che sostanziano il nome, correnti di senso che forse soltanto nelle pietre mute hanno un emblema accettabile. E però non c’è emblema, non c’è simbolo, non c’è allegoria, non c’è retorica in questa poesia tutt’altro che oracolare, tutt’altro che spettacolare. Essa pratica una spinta su chi legge, una iniziazione nel silenzio, un turbamento nell’assolutezza della cecità e dell’atto, una macula primaria che fa vibrare e differenzia lo stato iniziale, che è sempre il “non sapere”. Sono evitate le grammatiche del sapere, come accade nella poesia novecentesca, quel Parnaso che include Beckett, Eliot, Celan, Wallace Stevens. “In questa | giuria, voi, travi e | pupille rideste”. Trave, pupilla, giuria, noi siamo diventati in questa poesia e la benediciamo con l’amore che ci ha dato.
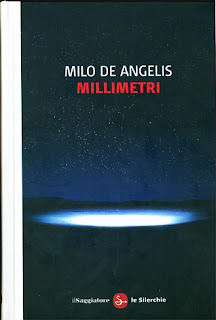
Nessun commento:
Posta un commento