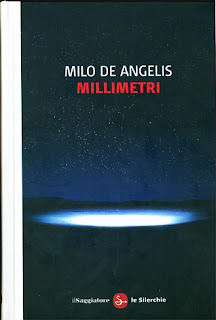Il libro del 1968 Lezioni di fisica e Fecaloro si apre con un capitolo composto da sei Lettere o egloghe, così come vengono denominate dallo stesso Pagliarani, inviate ad amici e importanti personaggi della cultura del tempo. Con quest'opera si passa dal racconto in versi di La ragazza Carla all’epica didascalica delle Lettere . In sostanza Pagliarani continua sulla strada della rielaborazione dei generi poetici che lui stesso aveva formulato in Funzione e ragione dei generi e che aveva sintetizzato nella formula finale: "Poemetto (genre) più poesia didascalica e narrativa (kind)". Dove i due addendi rappresentavano anche il punto in cui era arrivata la lingua poetica italiana: una sintesi di astrazione ermetica e arricchimento lessicale neorealista. Il passaggio definitivo avviene però solo dopo che il poeta abbia formulato e pronunciato il criterio di giudizio di una vera poesia sperimentale. Pagliarani dice, in occasione del congresso COMES (Comunità europea degli scrittori), svoltosi a Roma nel 1965, che una vera poesia sperimentale deve tenere presente questi tre punti cardine: «1) […] critica consapevole dei mezzi espressivi in situazione; 2) […] critica, a tutti i livelli, della funzione dell’operatore e del rapporto operatore-consumatore; 3) [...] critica della finalità dell’opera e/o funzione dell’arte.» Il risultato di queste tesi sono ora visibili nel contenuto e nella forma delle egloghe.
Nella prima lettera, rivolta a Fortini, Proseguendo un finale, Pagliarani riprende espressamente, come dichiarato nelle note al testo, la parole finali del poema scritto tra il 1954 e il 1957, La ragazza Carla, facendo del rapporto che unisce l’amore, la conoscenza e la forza il centro della sua missiva. La seconda lettera, rivolta a Pestalozza, dal titolo La pietà oggettiva, si concentra sul senso di una pietà laica nata dall’aver osservato le estreme possibilità dell’"essere uomo". La terza lettera, rivolta a Alfredo Giuliani, dal titolo Oggetti e argomenti per una disperazione, è un ragionamento in versi sul senso stesso del fare poesia. La quinta, dal titolo Dalle negazioni, si concentra sulla possibilità della raffigurazione in arte e nasce da uno sodalizio con il pittore Giò Pomodoro. La sesta, Come alla luna l’alone, inviata ad Achille Perilli, ruota tutta intorno al significato della parola rivoluzione.
La quarta lettera s’intitola come il libro Lezioni di fisica e sembra contenere il nucleo dell’operazione poetica che Pagliarani mette in atto in questi anni. Qui diventa evidente come Pagliarani assuma nel microcosmo delle relazioni quotidiane le leggi del macrocosmo. Le leggi della fisica equivalgono alle leggi supreme che regolano la storia e la dinamica dei corpi. Il poeta verifica la possibilità di organizzare intorno ad un corpo, quello della donna amata, lo spazio della storia: scrive rivolgendosi ad Elena, indirizzando a lei questa lettera. Il testo inizia come se fosse l’incipit di una biografia:
Cominciò studiando il corpo nero
Max Planck all’inizio del secolo (dispute se era il principio o la fine
del secolo), le radiazioni del corpo nero nella memoria
del 14 dicembre 1900
bisognava supporre che quanti d’azione fossero alla base
dell’energia moltiplicata per il tempo
Elena oh le sudate carte la luce
è una gragnola di quanti, provo a dirti che esiste opposizione
fra macrofisica e microfisica che il mondo atomico delle particelle elementari
è studiato dalla meccanica quantistica –scuola di Copenaghen-
e da quella ondulatoria del principe di Broglie che ben presto i fisici
si accorsero come le due nuove meccaniche benché basate su algoritmi differenti
siano in sostanza equivalenti: entrambe negano
negano che possano esistere precisi rapporti di causa e effetto
affermano che non si può aver studio di un oggetto
senza modificarlo
la luce piomba sull’elettrone per illuminarlo.
Pagliarani alterna una narrazione in versi volta al passato e un narrazione volta al presente, mescolando i toni epici con quelli drammatici come se echeggiasse nella sua poesia l'insegnamento di Lukács:
«Il poeta epico e il poeta drammatico sono entrambi sottoposti alle leggi generali della poesia, soprattutto alla legge dell’unità e a quella dello svolgimento; inoltre trattano oggetti simili e possono servirsi di ogni sorta di motivi; la grande, essenziale differenza consiste in questo: il poeta epico racconta il fatto come compiutamente passato e il poeta drammatico lo rappresenta come compiutamente presente.»
I primi versi di Lezioni di fisica accennano ad un passato prossimo e citano date e avvenimenti che hanno avuto una rilevanza storica assoluta per il genere umano. La data citata, il 14 dicembre 1900, si riferisce al giorno in cui Max Planck ha presentato la formula E=hv alla Società Fisica Tedesca. Questa equazione fissa la teoria dei quanti d’energia. La fisica meccanica di Newton veniva spazzata via per essere sostituita dall’analisi dei quanti e delle particelle subatomiche. Il tempo e lo spazio, perdono così la loro evidenza geometrico-matematica. Gli stessi nessi di causa ed effetto, che avevano regolato la fisica meccanica, vengono messi in crisi. Si poteva ancora parlare di moto, ma non si poteva più immaginare che un oggetto si muovesse in maniera predeterminata lungo un cammino. Da allora non è più possibile determinare un mondo conoscibile in sé. Ci sono invece vari mondi e varie raffigurazioni, vari "modelli visivi", chiamati da Einstein "gedanken experimente". Nel giro di pochi anni nascono gli studi di Planck, di Bohr e la scuola di Copenaghen, di Heisenberg, del principe de Broglie. "Il futuro non poteva più essere predetto, neppure in teoria. Nessun grado di accuratezza delle misure poteva controllare la mano del caso".
In questo scenario di rivoluzioni scientifiche si inserisce il concetto madre del corpo nero. Il corpo nero, in fisica, indica il principio limite dell’indeterminazione. Pagliarani dà inizio al suo scritto rimarcando l’effetto drammatico che esso ha nella memoria collettiva. Le radiazioni che propaga quel corpo informano tutto il secolo. La relazione tra il poeta e il suo personaggio muta radicalmente proprio a causa delle "radiazioni del corpo nero nella memoria". In questo preciso quadro storico, viene inscenato il dramma della voce poetante e di Elena. Nella composizione di questa lettera, e di tutto il libro Lezioni di Fisica e Fecaloro, agiscono due forze: la lingua, che rappresenta il dramma della relazione tra i due personaggi, è tutta permeata da calchi della poesia moderna (le sudate carte leopardiane), e dal linguaggio scientifico. La versificazione invece metabolizza le leggi della fisica quantistica. Tutta la lettera sulla fisica è anch’essa svolta per quadri e piccoli mondi. Riconosciamo in questo quanto detto e teorizzato da Lukács a proposito del Faust di Goethe:
«Ogni singola parte è drammatica, poiché in essa il destino di un uomo tipico (di uno stadio dell’evoluzione dell’umanità) si decide sotto i nostri occhi in base alla dialettica immanente delle sue interne contraddizioni: e l’esito è per lo più tragico, o almeno tragicomico. […] Al tempo stesso, ogni singola parte è epica, poiché, per dare in poche scene la necessaria autenticità al personaggio tipico, e con esso allo stadio corrispondente dell’evoluzione dell’umanità, l’ambiente sociale che sta attorno ai conflitti e persino il contesto storico degli oggetti sociali deve risaltare con una completezza che va ben oltre le esigenze del genere drammatico. Per questo le singole parti diventano piccoli mondi a sé.»
Ma nell’apparente polinuclearità di Lezioni di fisica, il corpo nero è il vero nucleo da cui nasce il dettato poetico. Questo suggerisce un’altra considerazione: se l’epica omerica organizzava il mondo e la successione delle generazioni intorno al corpo esemplare, si parla in questo caso di estrema visibilità dell’eroe, qui abbiamo il perfetto contrario. L’evoluzione di un genere, quello epico, va dall’esposizione del corpo esemplare all’indeterminatezza del corpo nero. Questo passaggio lo si può seguire nei versi che riempiono il quadro storico proposto dall’autore. L’occhio del lettore viene catturato da un fascio di luce, "la luce che piomba sull’elettrone per illuminarlo"; che è lo stesso che illumina le sudate carte di Elena che compaiono all’inizio della composizione ed è la stessa a cui si allude nei versi che seguono:
E io qui sto
e io qui sto Elena in gabbia e aspetto
il suono di un oggetto la comunicazione dell’effetto
su te, delle modifiche […]
Il poeta aspetta che ci sia il sobbalzo che ritorni la relazione tra il sé e Elena, l’oggetto d’amore, l’eroina che attende d’essere illuminata. Lo stesso nome dell’amata, Elena, potrebbe non essere casuale e suggerire un’altra operazione metalinguistica di Pagliarani. Ricordiamo che Elena è la protagonista della seconda parte del Faust di Goethe. L’eroina omerica occupa una scena del poema e rappresenta la bellezza assoluta irrecuperabile che è alle nostre spalle. Il suo mondo è finito, come lo sono gli altri mondi che si presentano di volta in volta agli occhi dello scienziato e alchimista Faust. Secondo la famosa lettura di Lukács, Goethe vuole sancire così l’essenza frammentaria del poema epico moderno ponendo la perfezione spirituale in qualcosa che è da venire, che non è dato nella dialettica delle cose umane. Il nome di Elena ripreso da Pagliarani potrebbe suggerire un riporre in questione la ricerca della bellezza nel mondo finito dei viventi.
Da parte sua, la voce poetante conosce e ormai non può non vedere la relazione d’indeterminazione di Heisenberg; sa che "l’indeterminazione è dovuta alla perturbazione arrecata ad un oggetto nell’atto di osservarlo". I versi quindi non illuminano il corpo di Elena nella sua interezza. L'incontro tra la voce del poeta e l’eroina della narrazione non si dà una volta per tutte; non funziona la raffigurazione come rappresentazione iconica della donna amata. Nella relazione tra la voce del poeta ed Elena c’è quindi un sobbalzo, una modifica dovuta all’incontro. La luce che investe, modifica e rimanda l’incontro definitivo. Elena non arriva mai a farsi personaggio. Si prospetta così nel testo uno scenario fatto di sole forze. Ogni relazione muta i soggetti in gioco, ogni incontro di corpi vale come messa in atto di una reazione. All’inizio della nuova èra atomica non esiste sostanza che tenga, paradigma che duri, non si dà alcuna idea ultima della cosa o dei soggetti. La voce poetante è la consapevolezza sempre parziale, partigiana, di questa verità.
Passando ad un tono ironico, la voce del poeta continua la sovrapposizione di identità tra fisica e poesia. In un gioco di scambio d’identità chapliniano, sembra (ma è solo un’illusione presente nei versi) che con una tintura dei capelli, il poeta possa assomigliare anche nelle fattezze somatiche ad Einstein. Ogni verso è ora una rifrazione e un attrito tra il corpo nero e il corpo illuminato della storia del vissuto personale e collettivo:
Io cosa vuoi sapere se tieni duro il muscolo cardiaco
è ormai provato che sono una pellaccia, mi tingerò i capelli Einstein piuttosto
e la sua chioma te lo immagini quando dovette prendere la penna
scrivendo a Roosevelt "Caro presidente facciamola
l’atomica, sennò i nazi" l’azione dell’energia
dell’energia moltiplicata per il tempo l’epistassi
anzi il sangue dal naso, diceva Pasqualina alla tua età, il sangue dal naso che ti [libera
La simbiosi qui è perfetta. L’energia atomica è già la legge universale che condiziona nel quotidiano la vita dei molti, come si capisce da questo nuova scena. Effetti simili li ritroveremo nella narrativa postmoderna di Pynchon. Qui l’indeterminazione prefigura il terrore. La perdita del proprio mondo, in quanto spazio creato da relazioni tra sé e le persone amate, coinvolge l’intero universo:
Se si vuole sapere se A è causa dell’effetto B
se il microggetto in sé è inconoscibile
se l’onda di de Broglie per i fisici di Copenaghen
non è altro che l’espressione fisica della probabilità posseduta
dalla particella di trovarsi in un luogo piuttosto che un altro onda cioè generata
dalla mancanza di un rigoroso nesso causale in microfisica
Perciò l’atomica
per la legge dei grandi numeri la probabilità tende alla certezza
Perciò l’atomica
Poi la teoria dell’onda pilota e quella, così cara al nostro tempo
Della doppia soluzione, e se esiste il microggetto in sé, se la materia
Può risponderci con un comportamento statistico
Dio gioca ai dadi
con l’universo? E se la terra
ne dimostrasse il terrore?
Anche in questo passo tornano accenni alla storia della fisica e delle dispute all’interno degli studiosi che si occupavano di fisica atomica. Sono riportate le leggi che regolano la composizione della materia. Lo spazio testuale che ora si apre ci presenta il principe de Broglie che ha dedicato la sua vita allo studio della orbite dell’elettrone intorno al nucleo. Dai suoi studi è nata l’idea dell’elettrone onda. Per de Broglie l’elettrone è un’onda che segue un’orbita fissa intorno al nucleo. L’onda pilota appunto. Questa scoperta aveva significato rimettere ordine nel mondo della microfisica; ossia, significava la possibilità di una soluzione statistica alla composizione della materia. Ma la scoperta di de Broglie fu contestate dalla scuola di Copenaghen e dal suo rappresentante più illustre Bohr. Einstein decise, allora, di scrivere una lettera a quest’ultimo nella quale compare la famosa frase "Dio non gioca a dadi!". Bohr rispose ad Einstein: "Einstein, smetti di dire a Dio quello che può e non può fare!"
Il nuovo quadro approfondisce le conseguenze storiche che si intuiscono dalla lettera tra Einstein e Bohr:
Non gridare non gridare che ti sentono non è niente mentre graffio una poltrona
Herman Kahn ha già fatto la tabella
delle possibili condizioni postbelliche, sicché 160 milioni di decessi in casa sua
non sarebbero la fine della civiltà, il periodo necessario per la ripresa economica
sarebbero 100 anni; va da sé che esiste, egli scrive un ulteriore problema
quello cioè se i sopravvissuti avranno buone ragioni
per invidiare i morti
Quanta gioia mi dai quando ti stufi
di me, quando mi dici se scriverai di me dirai di gioia
e che sia gioia attiva trionfante e che sia una barzelletta
spinta, magari […]
All’episodio della lettera si passa alle conseguenze del dopo guerra e poi di nuovo alla relazioni dell’io-personaggio con Elena. C' è sempre un tenersi e un richiamarsi di quadro generale e particolare, di scena epiche e drammatiche, di tono serio e comico. La voce in primo piano, che intreccia la relazione tra l’io ed Elena, emerge ora come se risorgesse dal limite estremo dell’indeterminazione. Qui il poeta cerca la sua onda pilota. Elena con la sua presenza, con il suo nome, è la sua sola costante. Anche il poeta affronta il problema della "doppia soluzione": in un microcosmo indefinibile in sé, esiste un’onda pilota che guida lo sguardo. E’ una presenza che si sfrangia come un campo magnetico nell’aria.
Il disastro nucleare è già compiuto. I suoi versi sono è già compresi in questa metafora. Particolarmente suggestiva è la sua voce che si rivolge ad un’Elena post-nulceare. Si fa la stima dei morti e, come fantasmi in cerca del loro corpo, riemergono le voci dei vivi. In realtà i riferimenti di Pagliarani sono ancora oggettivi e reali. Lo strappo della relazione coniugale, "mentre graffio una poltrona", diventa guerra totale. Herman Kahn era un fisico che contemplava l’"impensabile", ossia, utilizzando le applicazioni delle teorie dei giochi, stimava quanti morti ci sarebbero stati nel mondo se fosse scoppiata una guerra atomica. Si era in piena guerra fredda e la figura di Kahn faceva coincidere la fisica atomica con una inedita sociologia mortuaria. La società si regolava, non per una previsione sulla durata della vita media, ma su quella della stima di morti ammazzati e sulla possibilità di ripresa da questa catastrofe. La figura di Kahn ha in effetti un’intensità simbolica enorme: è il demiurgo della conoscenza negativa. In questo scenario il poeta si rivolge a Elena parlando della gioia. Nella relazione con Elena la necessità che emerge, da parte dell’io personaggio, è quella di "riassuefarsi alla gioia": "quando mi dici se scriverai di me dirai di gioia […]" E sarebbe forse il caso di ripensare cosa ha significato l’uso frequente che questa termine ha avuto tra la metà degli anni sessanta e l’inizio dei settanta nei poeti italiani. I partigiani della gioia sono coloro che guardano il mondo a partire dalla sua fine. Le Pastorali di Giorgio Cesarano, come le egloghe di Pagliarani, mettono in scena una relazione amorosa che in realtà descrive il quadro della storia contemporanea. In Cesarano però il mondo è raggelato dal nulla ma proprio questo essere proiezione del nulla fa dei soggetti, dei corpi, un inizio assoluto, nuovo. La gioia è il sentimento di chi ha l’apocalisse alle proprie spalle e vede il mondo sotto il segno della speranza che nasce da una disperazione estrema. Ogni relazione in questo caso è necessaria come la trama che struttura il mondo. La gioia, più che un sentimento, è un vero e proprio modo di guardare. Lo spazio storico è ridotto a condivisione di una catastrofe. Il futuro non è più immaginabile. Di fronte a questo l’io poetico non è infelice, perché la felicità e l’infelicità riguardano la rappresentazione del mondo ancora non invaso dall’onda lunga del nulla, le stime di Kahn, la guerra fredda. Chi conosce il nulla, come fondo ineliminabile e visibile, come tangibile realtà, non può essere felice; tutt’al più può essere gioioso. Pagliarani riprende la versificazione da questo nuovo spazio storico. Anche lui ha una sociologia mortuaria alle spalle ma l’indeterminazione non permette nessuna definizione ontologica (anche se nichilista o assolutamente negativa) del mondo; nessun lamento esistenziale . Al poeta è permessa la sola partecipazione alla struttura aperta del vivente. Per questo motivo l’io-personaggio della sua egloga non può riassuefarsi alla gioia. Ancora rivolti ad Elena, i versi finali recitano così:
Ma cosa credi che non sia stufo anch’io di coabitare
con la mia faccia la mia pancia
anche in noi c’è dentro la voglia
di riassufarci alla gioia, affermare la vita col canto
e invece non ci basta nemmeno dire no che salva solo l’anima
ci tocca vivere il no misurarlo coinvolgerlo in azione e tentazione
perché l’opposizione agisca da opposizione e abbia i suoi testimoni.
Qui neanche la gioia è permessa, quantomeno non è permesso come sentimento comune. Questo perché lo sguardo sulla fine non è lineare, è rimosso di volta in volta dai diversi modelli, dai diversi paradigmi. Pagliarani sa che in uno scenario di innovazione costante della conoscenza e dei suoi paradigmi anche il nulla, che secondo le teorie esistenzialiste fonda la progettualità dell’uomo contemporaneo, è rimosso, non è più raffigurabile come esperienza collettiva. E qui la parole usate da Albert Camus nel Le Mythe de Sisyphe sembrano quanto mai adatte:
«Ma voi parlate di un invisibile sistema planetario in cui gli elettroni gravitano intorno ad un nucleo. Cercate di spiegarmelo con un’immagine. Mi accorgo allora che siete ricorsi alla poesia: io non "conoscerò" mai. Ho appena il tempo di sdegnarmene, che voi avete già cambiato teoria. Così questa scienza, che tutto doveva insegnarmi, finisce in una ipotesi, la lucidità naufraga nella menzogna, l’incertezza si risolve in opera d’arte.»
Questo è evidente fin da La ragazza Carla, dove l’assenza di tradizione e fondazione non permette alcun sentimento luttuoso. Ora al poeta è solo permesso di resistere e misurare lo spazio che gli si presenta davanti ogni volta che si avverte un sobbalzo, la presenza-assenza di un corpo. I versi finali del nostro testo-lettera sono una sintesi di poetica. Ancora una volta ricompare la sforzo di "convivere con la propria faccia", con l’espressione della propria identità. Nel Diario milanese la faccia era quella immobile e passiva degli oggetti quotidiani; era il dopoguerra, il 1948, e un Pagliarani espressionista scriveva: "drizzati su una mensola, il pupazzo/ meccanico invitava: Tira, tira,/ tre palle un soldo e in premio una bottiglia./ Ma la mia faccia, mamma, gli assomiglia". In La pietà oggettiva, la faccia scompare del tutto, "non si salva". Già siamo nel paradigma delle fisica atomica che cancella ogni verità ontologica, ogni possibilità di raffigurare un corpo e con esso le relazioni che fanno la storia: "[…]Certo/ qui non si salva la tua età né la mia faccia/ vorrei vedere che non fosse così/ che si compisse nei versi la catarsi che bastasse/ questa pietà oggettiva che ci agghiaccia".
Di fronte ad Elena, invece, ritorna lo sforzo, la fatica di convivere con la propria faccia: "ma cosa credi che non sia anch’io stufo di coabitare con la mia faccia". Lo sforzo è quello di sostenere le identità in gioco. Questo significa misurare l’opposizione tra le forze: "ci tocca vivere il no misurarlo coinvolgerlo in azione e tentazione perché l’opposizione agisca da opposizione e abbia i suoi testimoni". Dove la tentazione è la spinta alla dispersione in un tempo privo di una certezza assoluta, mentre l’azione è la forza contraria che vale come resistenza alla dispersione. Questo contrasto di forze bisogna viverlo, misurandolo. La misura è la propria voce, il proprio spazio poetico. La propria identità è il risultato di questo scontro di forze. Lo sforzo epico si conclude nel porre se stessi, il proprio personaggio, la propria identità, come centro dello scontro di forze opposte. Così come avveniva nelle battaglie omeriche, in cui gli eroi erano mossi dalla dynamis e dallo scontro di forze, come ha fatto notare la Weil in suo famoso scritto. Ma nel contesto classico l’esemplarità delle gesta dell’eroe, sotto gli occhi dei padri, vale come trasmissione di valori, come spazio ideale, continuum di una tradizione. In Pagliarani perché lo spazio poetico si tenga, e si tengano con esso l’insieme degli spazi epici e drammatici che lo compongono, c’è bisogno di altri testimoni. La comunità che il poeta scorge alla fine della sua lettera a Elena, non è più quella della tradizione, non è ancora dettata dalla speranza utopica in un mondo nuovo a venire, ma è quella presente ed effettiva dei testimoni. I testimoni sono color che certificano il proprio essere parte costitutiva di una differenza irriducibile. Lo sguardo che trattiene nella presenza la relazione tra il poeta e il suo personaggio è il nostro, è lo sguardo di chi osserva lo spazio letterario che muta.